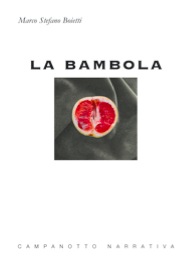Ultimamente si parla spesso, tanto tra le élites intellettuali quanto tra la gente comune, di uno dei mali del-la nostra epoca: la solitudine. Oggi, in effetti, si vive un paradossale isolamento, sociale e individuale. Le persone non pensano più (o, comunque, lo fanno di meno) con la propria testa, ricorrendo al surrogato di un citazionismo ormai esasperato per esprimere le proprie idee. In altre parole, ai nostri tempi sempre più di rado si esprime compiutamente il proprio pensiero e, quando si desidera farlo, si sceglie la comoda soluzione di far proprie parole altrui. Una possibile causa di questo dilagante fenomeno è da ricercarsi proprio nella solitudine. Non si esce più, non ci si confronta più, non si dialoga più. Quantomeno fisicamente. Per-ché, invece, sui social network lo si fa di continuo. Soli ma in contatto con gli altri: questo è il paradosso. Ma non è questa la sede per una lezione né di sociologia né, tantomeno, di antropologia culturale e lungi da chi scrive soffermarsi su un argomento, quello della solitudine dei nostri tempi, che rischia addirittura di diventare banale tanto si trova al centro del dibattito contemporaneo.
No, il tema della solitudine qui serve solo come premessa, come introduzione al vero oggetto della nostra riflessione: l’abbandono. L’abbandono, va da sé, è una diretta conseguenza della solitudine. E, ne “La bambola”, il tema dell’abbandono è quello attorno al quale si sviluppa tutto l’intreccio del romanzo. La protagonista femminile (non la definiremo l’ “eroina” per ragioni che illustreremo in seguito) racconta subito del suo passato: ha abbandonato l’uomo che amava per permettergli di esprimere sé stesso. Si può amare più volte, mentre per diventare qualcuno abbiamo solo una possibilità nella vita: questo il ragionamento che sta dietro la scelta della donna. Una decisione che appare dettata dalla più limpida razionalità, da una forza interiore d’acciaio.
Ma non è questa la donna che, poco a poco, procedendo
nella lettura, arriviamo a conoscere. Anzi. Si tratta di una donna
estremamente fragile, che suscita compassione, a tratti persino
pena. È una donna che viene sedotta, che si dà interamente al
proprio partner, ma che, inevitabilmente, viene abbandonata.
Ed ecco qua il ritratto della Donna così come è stata concepita per
secoli, come permane ancora oggi nell’immaginario sociale
dell’Occidente: la donna che dà tutto, che si umilia, che aspetta.
Nessuna rivendicazione politica, nessun gender study, nessuna legge
possono mutare i contorni di questo ritratto: la donna che ci si
aspetta di avere accanto a sé, la donna che magari anche si ama, è
quella che si dà per scontato che sopporti, che attenda e che
perdoni. Tutte le donne soffrono con lei, la comprendono, ma allo
stesso tempo rivedono in lei il proprio errore, la propria
debolezza di fondo. Curiosamente, è un personaggio minore a gettare
luce sul tema della fragilità femminile: la cugina. Solo lei, in
una sala da pranzo gremita di gente, ha il potere di calamitare
l’attenzione generale, di creare un pathos tale da sospendere il
tempo, nel momento in cui chiede al pubblico che segue con muta ma
viva attenzione: “Cosa fareste se qualcuno che amate vi
abbandonasse?”. “L’amerei lo stesso, e con la stessa intensità”,
risponde la folla, rapita dall’emozione. Dare senza aspettarsi di
ricevere, amare e soffrire, comprendere e perdonare: in fondo, in
tutto questo c’è ben poco di epico. È la nostra quotidianità. È la
quotidianità delle donne. Che sono, dopo-tutto, eroine. Ma che il
mondo vedrà sempre, soprattutto, come bambole.
Giulia Bianchi